|
|
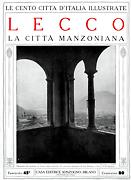 |
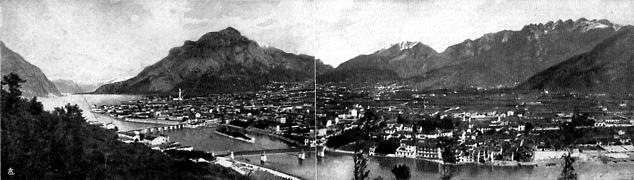 |
|
Quel «gran borgo» che quando il
Manzoni prendeva a scrivere la sua impareggiabile «canta
favola»; or sono cent'anni, già s'incamminava a
diventar città, da un pezzo è ormai un'ampia,
moderna e civilmente laboriosa cittadina il cui comune, secondo il
censimento 1921, conta 13.141 abitanti e tutto il territorio del
circondario 157.354.
Non toccò a Lecco la sponda più amena del
magnifico Lario, ma la più imponente e operosa:
ché se a' piedi delle alte montagne brulle e negre
strapiombanti in più luoghi a dirittura giù nelle
acque non si svolgono i deliziosi meandri dei giardini verdi attorno
alle ville sontuose, vi si adagiano, o meglio vi si aggrappano, in
compenso, gli opifici fumosi d'onde il prodotto del lavoro umano esce
in gran copia per tramutarsi in moneta corrente. E questa
operosità degna delle fucine favoleggiate nelle
latèbre del siculo Mongibello non è d'oggi, ma
data da più di cent'anni, poi che già ai tempi
del Foscolo le ferriere lecchesi destavano gli echi delle gole montane
e delle insenature del lago, onde il grande poeta dal troppo sensibile
cuore cantava alle Grazie, nella sua originale concezione sintetica di
cose dissonanti, dalle quali sa trarre un concento di amabili armonie:
Così quando più gaio Euro provoca
sull'alba il queto Lario, e a quel sussurro
canta il nocchiero, allegransi i propinqui
liuti e molle il flauto si duole
d'innamorati giovani e di ninfe
sulle gondole erranti; e dalla sponda
risponde il pastorel colla sua piva:
per entro i colli rintronano i corni
terror del cavriuol, mentre in cadenza
di Lecco il maglio domator del bronzo
tuona dagli antri ardenti: stupefatto
pende le reti il pescatore ed ode.
|
|
|
|
Una prova della importanza economica assunta da
Lecco è il suo mercato bisettimanale, mercoledì e
sabato, il più frequentato della regione ed uno dei
più affollati della Lombardia. Pier Ambrogio Curti nella sua
simpatica Guida del Lago di Corno e del Pian di Erba così lo
descrive «È detto che il mercato di Lecco sia una
gran cosa, massime ai sabati d'ottobre, e ognun vi corre che stia in
villa, o lungo il lago, o nel vicino Pian d'Erba, o nella restante
Brianza superiore. Gli è che ognuno serve di spettacolo
all'altro: giunge una carrozza, ne giunge un’altra, gli uni
attendono a vederne scendere gli altri; son persone che si conoscono,
che si salutano, che si stringono la mano, si baciano, si scambiano
notizie e complimenti; poi a braccetto si passeggia a veder altri, poi
si parla e si sparla di tutti; si ingombra il caffè; si
impegna a fermarsi per la sera al teatro, che per consueto ha in
autunno buona compagnia di canto; poi, se sì, si va
all'albergo, il Leon d'Oro o la Croce di Malta, forniti d' ogni
comodità; se no dopo un paio d'ore, chi rimonta in carrozza,
chi riascende il vapore; gli uni vanno di qua, gli altri di
là, tutti ritornano alle loro ville a diffondere alla loro
volta le notizie e i pettegolezzi uditi, e a domandarsi spesso: ma
infine, che cosa v'era a Lecco? Perché ci si va? E a
malgrado che la risposta che ognun si dà a se stesso non
contenga grande costrutto pure il sabato successivo vi si
ritorna».
Digradando dai colli che fanno scalino a più alte prominenze
fino ad affacciarsi sul lago in uno schieramento poco regolare, avendo
a sinistra la foce per cui il lago si va pacatamente cangiando in
fiume, cavalcato subito da un lungo ponte costruito in tutta pietra al
tempo di Azzone Visconti, fra il 1336 e il 1338, rifatto dal conte di
Fuentes governatore dl Milano nel 1609, allungato e restaurato
più volte, e finalmente pur troppo del tutto trasformato ed
agghindato negli ultimi anni con due ringhiere in ferro ai lati,
sì che di medioevale non serba neppur l'ombra, e a destra
affacciandosi ad un ampio seno cui sovrasta il monte San Martino, Lecco
si presenta, a chi dal lago le muove incontro, pittoresca ed amena.
Dietro le sta il Resegone con la sua cresta grandiosa frastagliata di
denti dolomitici.
SPUNTI
STORICI
Che Lecco, di oscure origini, dal nome forse
ellenico (latino Leucum, come Leucade, bianca), dopo aver seguite le
sorti delle due regioni lariana e briantea dalla favolosa epoca degli
Orobi alla formazione dei Comuni divenisse nel medio evo un importante
castello, è facile comprenderlo dalla sua giacitura che la
poneva al comando d'uno dei primi passi lombardi; ma delle sue
fortificazioni non restano che ruderi di torri, una delle quali presso
il Municipio, ridotta a carceri, l'altra accanto alla chiesa maggiore,
adattata a campanile. Sofferse anche Lecco col suo territorio
dell'ambizione delle famiglie più potenti e dei principi,
quando i Comuni divennero signorie. Contesa quindi prima fra i
ghibellini Longhi ed i guelfi Benalio, poi tra i Rusca e i Visconti, a
più dolorose vicende soggiacque per le guerre tra Filippo
Maria e la Repubblica di • Venezia, della quale stette alcuni
anni in potere (1428-1452), sempre però allo stato
insurrezionale, avendovi mantenuto i Visconti e gli Sforza un loro
forte partito, e in questo tempo combatterono nel lecchese con varia
fortuna i più celebri capitani dell'epoca: Carmagnola,
Facino Cane, Piccinino, Colleoni, Cornaro, ecc.
In trambusti guerreschi fu nuovamente il territorio di Lecco quando il
Medeghino (Gian Giacomo de' Medici) tentò di formarsi un
principato delle terre del Lario e della Brianza e nel 1512
s'impadronì per sorpresa del grosso borgo, intitolandosi
conte di Lecco e coniando monete con tale qualifica; poi
tornò in quiete, o più tosto in oppressione
stabile, sotto gli Spagnoli, per causa de' quali sofferse nel 1629 il
famoso saccheggio dei Lanzichenecchi che andavano all'assedio di
Mantova e portarono la peste descritta dal Manzoni. Il solo borgo di
Lecco, nel contagio, si afferma perdesse 511 persone.
Fragor di guerra rimbombò ancora tra le rocciose montagne
del lago nel 1799, quando Francesi ed Austriaci si scontrarono dinanzi
al famoso ponte visconteo, che fu mutilato d'un arco d'ambe le parti
dai due prudenti nemici. Nel '48 i Lecchesi furono tra i primi popoli
rurali che, all'annunzio della insurrezione di Milano, fecero
prigioniero il presidio austriaco: quindi armatisi, corsero a Monza,
aiutarono quei cittadini a liberarsi dell'imperiale e regia guarnigione
e con nuovi rinforzi giunsero a Milano, dove entrarono dal dazio di
Porta Comasina, dopo una viva scaramuccia, primo soccorso fraterno dei
provinciali ai combattenti milanesi. A Milano tornarono nell'agosto
dello stesso anno i Lecchesi per difenderla dal nemico che, inseguendo
i vinti Piemontesi, l'aveva investita con grandi forze, ma giunsero
quando già era stato stipulato il trattato di resa noto col
nome di Armistizio Salasco, e non restò loro che tornarsene
e disperdersi in fretta.
«Pochi, ma buoni» veramente sono gl'ingegni fioriti
su la terra fertile e nell'aria fina di Lecco. Rammentiamo anzi tutto
Girolamo Morone, lo sfortunato ministro dell'ultimo duca di Milano,
Francesco Il Sforza, per debito di cronologia, ma più caro
agli Italiani è il nome di Antonio Stoppani (1824-1893),
geologo e letterato di mente elettissima, probo e liberale sacerdote; e
di simpatica luce splende il nome del poeta Antonio Ghislanzoni.
Né degni d'oblio sono i nomi dello storico locale dottor
Giovanni Pozzi, del musicista Luigi Vicini, dell'intagliatore Giacomo
Mattarelli, che dedica ventidue anni ad un modello in legno del Duomo
di Milano. Lecchese era pure, com'è notorio, la famiglia dei
nobili Manzoni.
|
|
|
|
I MONUMENTI
Lecco
- l'abbiam detto - è una cittadina bella, simpatica, pulita,
moderna; ma tutto quel che v'è di apprezzabile, specie dal
lato architettonico, non ha grande importanza né storica ne
artistica. La sua chiesa prepositurale, intitolata a San
Nicolò, situata sopra un poggetto a specchio del lago,
è una grandiosa, fabbrica del secolo scorso, architettata
dal classico Bovara; la più antica chiesa di Santa Marta
venne anch'essa resa irriconoscibile da restauri secenteschi e
successivi. Il palazzo municipale, su la piazza del Mercato,
d'architettura barocca, nulla più conserva di
caratteristico. Solo ha nell'interno un buon ritratto del Medeghino, il
leggendario pirata del Lago di Como. Il teatro è un edificio
pure di stile neoclassico. Interessanti, se non di prim'ordine, sono a
Lecco i monumenti.
Già sul piazzale della stazione, tra il verde dei
giardinetti, troviamo il busto in bronzo del Ghislanzoni, del. Bezzola
(1894), scultura viva e di moderna arditezza che ben ritrae lo
scapigliato librettista dell'Aida, del quale ricorre adesso il
centenario natalizio; poi, nella piazza Garibaldi, il monumento in
marmo all'eroe di Caprera dello scultore Francesco Confalonieri di
Costa Masnaga in Brianza (1884), autore anche del monumento in bronzo
al Manzoni nella omonima piazza (1891). Quest’ultima opera
rivela tutto lo studio, non solo, ma anche l'amore posti
dall’artista nel lavorare un ricordo monumentale che si
voleva degno del grande italiano, e l'esito felice dello scopo. Il
Manzoni è raffigurato seduto sopra una poltrona imbottita in
atto di contemplare il paese scelto a teatro del suo romanzo: i tre
diligenti altorilievi pure in bronzo decorano il piedestallo. Dinanzi i
due Promessi finalmente sposati a capo del villereccio corteo nuziale:
Renzo offre il braccio destro a Lucia, che, timida, rimane indietro,
mentre con la mano sinistra, alto levata, toltosi il cappello, saluta
con paesana gaiezza bene espressa e dal gesto e dal volto. Da un lato
il ratto di Lucia, che invano si dibatte fra le braccia vigorose degli
sgherri, e dall'altro il padre Cristoforo che con un gesto imponente
mostra a Renzo il suo ricco e borioso rivale disteso mezzo nudo su un
pagliericcio al Lazzaretto.
Fra non molto si dice che Lecco, ai tre buoni monumenti che possiede,
aggiungerà quello di Antonio Stoppani, altra gloria pura e
gentile di questa simpatica cittadina.
|
|
|
|
LE MEMORIE DI A. MANZONI
Lecco
ed il suo territorio hanno un'importanza grandissima, tra i primi
luoghi d'Italia, per essere stati scelti a scenario dei Promessi Sposi
di Alessandro Manzoni. Perciò per dire Bene di Lecco io
credo necessario accennare alle memorie che A. Manzoni vi ha lasciato
di sè e dell'opera sua.
E’ noto che la famiglia Manzoni era originaria da Barzio
nella Valsassina, la valle incantevole che da Ballabio sopra Lecco, si
prolunga formando un gran gomito a Bellano. Ma il bisavolo di A.
Manzoni nel 1710 era disceso a stabilirsi a Lecco, in una
località detta il Caleotto, e nella cronachetta dei
Cappuccini di Pescarenico, nel 1717, si fa già cenno della
signora Margherita Canzona - singolare benefattrice - che aveva
eseguito dei ricami per la chiesa del Convento.
Però la casa settecentesca della famiglia Manzoni, ancor
oggi esistente, fu ricostruita certamente dopo il 1770, essendone stato
architetto l'abate Giuseppe Zanoia, canonico di Sant'Ambrogio e
professore di architettura all'accademia di Brera in Milano, il quale
nacque nel 1752.
Intorno alla bella casa si irradiavano i possedimenti della famiglia
Manzoni, che si prolungavano giù fino a Pescarenico contro
l'ortaglia del convento, e su oltre Acquate e Germanedo fino al Pizzo
d'Erna, il più grande contrafforte del Resegone.
Don Alessandro è il primo della famiglia che nasce a Milano,
e se la grande metropoli lombarda ha avuto la fortuna di avergli dato i
natali, lo deve ad una debolezza della madre Beccaria, la quale
dimostrava poco affezione alla vita provinciale, e tendeva a tirare
tutta la famiglia verso la città. Ma il neonato
Alessandrino, è mandato subito a respirare l'aria pura delle
sue valli e dei suoi monti. Egli è collocato a balia, alla
Costa, una cascina che fa parte dei Comune di Galbiate, sulla cresta
della collina che dipartendosi dal monte Barro sale verso Mozzana e da
dove si gode un panorama che sembra incantato. L'antica cascina ora si
chiama Alessandro Manzoni, e la culla che ha ascoltato i primi vagiti
del grande poeta, dopo aver raccolto altri bambini di più
umili condizioni, ora è andata a finire nel museo di Lecco
insieme ad un altro cimelio interessantissimo: il corredo di battesimo.
Passati i primi anni d'infanzia, il ragazzetto veniva posto a studiare
in collegio; ma al ritorno delle vacanze egli correva lassù
a rivedere i suoi monti ed il suo lago. Ma vi sarà stato
volentieri? Io oso supporre che no; chè la caccia dei
copertoni nel suo paretaio presenta aspetti di crudeltà
verso gli animali e niuna valutazione del tempo, che poco dovevano
adattarsi alla sua mente laboriosa ed alla raffinata bontà
del suo animo.
Forse quando l'altrui volontà l'avrà obbligato a
rimanere accovacciato là dentro, avrà spiato
attraverso le feritoie i mutevoli e pittoreschi aspetti del lago, e il
partire e il tornare dei pescatori, e forse fin d'allora
avrà notato i particolari dello staccarsi delle barche dalla
riva, di cui dettava poi l'impareggiabile descrizione.
Antonio Stoppani, che più tardi veniva a villeggiare nell'ex
convento dei Cappuccini ed era anche diventato proprietario del
paretaio Manzoni, narra che il Lisandrino una sera era venuto a
Pescarenico mentre nella chiesa si impartiva la Benedizione col SS.
Sacramento, e un padre l'aveva invitato a servire da chierichetto. E
dice, che quel fatto doveva aver lasciato una profonda impressione
nell'animo del fanciullo, che non dimenticava più quel
padre, forse il Padre Cristoforo da Barzio probabilmente suo lontano
parente, tanto che avrebbe tolto da lui il nome e la
personalità fisica e morale, per tratteggiare la magnifica
figura del suo personaggio immaginario.
Aleesandro Manzoni continua a ritornare alla cittadina de' suoi
antenati fino all'età di 33 anni, tanto che si sa di certo,
che fra i 31 e:32 anni egli era a capo dell'amministrazione comunale di
quel gran borgo. Si vuole anche, ma forse saranno dicerie, che il tipo,
dell'Azzecca Garbugli l'abbia tratto appunto da un suo avversario
elettorale.
Nel 1818, per dissesti finanziari provocati dal suo procuratore
disonesto, egli doveva vendere tutte le case ed i luoghi avuti
dall'eredità paterna, ed accontentarsi della villeggiatura
di Brusuglio, che gli era venuta dalla mamma come eredità
dell'Imbonati. Certo, Manzoni avrebbe preferito conservare la casa
avita, dove nella cappella di famiglia era sepolto il padre suo,
dov'egli era cresciuto, dove lo richiamavano tante memorie!
Lassù egli si interessava di agricoltura, e con competenza,
come ne fa fede anche la scientifica descrizione dell'ortaglia di
Renzo, aveva di fatto condotta egli stesso l’acqua nel suo
giardino; e lassù al ritorno di Parigi aveva curato la
decorazione del grande salone, a grisaglie mitologiche, secondo l'uso
del tempo. Io oso credere che l'immortale Romanzo, abbia avuto origine
appunto dal suo grande dolore in dover abbandonare quei luoghi che gli
erano impressi nella mente non meno che lo sia stato l'aspetto de' suoi
più familiari. Quell'addio inimitabile ne rimarrà
la più grande prova !
Alessandro Manzoni nel tracciare il disegno del suo capolavoro, ha
fatto come un artista che intende dipingere un quadro., non
semplicemente realistico, ma pieno di poesia e di
spiritualità. Egli ha scelto un ambiente poetico, il suo :
vi ha segnato alcuni punti, che pur essendo tratti dal vero, concorrono
all'armonia della sua descrizione ; il lago, il Resegone, Lecco,
Pescarenico, e poi vi ha raggruppato intorno trasportandoli a piacere,
quegli altri luoghi della valle che maggiormente lo interessavano,
nascondendone il nome che sarebbe tornato oramai dannoso all'azione di
tempo e di luogo che erano nella sua mente, e svestendoli di tutti quei
particolari che artisticamente avrebbero nociuto.
Egli descrive, ad esempio, il Palazzotto di Don Rodrigo. Chi ha voluto
cercarlo dietro le indicazioni del romanzo, è riuscito col
rompersi il capo inutilmente ; invece la voce comune lo ha sempre
indicato su allo Zucco di Olate. Su quel promontorio esiste ancora una
bella costruzione cinquecentesca, che fu degli Arrigoni e nella quale,
ai primi del secolo scorso, facevano convegno i patrioti. Forse ad
alcune di queste riunioni prese parte anche il giovane Manzoni e forse
in alcuna occasione può essere stato. accolto con poca
cortesia qualche padre del convento. Così egli descrivendo
la sala del dottor Azzecca Garbugli, parla dei dodici Cesari. Questi
dodici Cesari erano invece appesi nella sua casa al Caleotto ed ora
cinque di essi sono passati dalla famiglia Scola che ne aveva comprato
lo stabile, al museo di Lecco.
Chi vorrà trovare il paesello di Renzo e di Lucia,
dovrà almanaccare per un pezzo. Alcuni lo vogliono ad
Acquate, altri ad Olate. Ma in un caso non corrisponde la posizione
della chiesa, nell'altro non corrisponde quella del bivio col
tabernacolo, e per nessuno la distanza dallo Zucco. Nel romanzo si
legge che l'ombra acuta del campanile proiettata dalla luna, si
rifletteva sulla piazza della chiesa.
Nè il campanile di Olate nè quello di Acquate
hanno il cono cestile come parrebbe indicato dalla descrizione. A meno
che non si voglia dire, senza documentarlo, che il campanile piatto di
Acquate sia stato smantellato ; e sarebbe il solo che per il, giro
della luna potrebbe dare l'ombra sulla piazza della chiesa. In tutto il
territorio di Lecco, l'unico campanile coronato da un cono cestile
è quello di Malgrate, ma nessuno crederà che
questo possa essere il paese di Lucia; così sulla strada di
Malgrate s'incontra ancora uno di quei tabernacoli con anime e fiamme a
color di mattoni; ma pur qui sarebbe temerario cercare il bivio dei
bravi.
Si sa però che Manzoni giovanetto si recava a Malgrate in
casa Agudio. Non è improbabile che nel suo viaggio, come si
sarà intrattenuto a guardar dal ponte l'acqua passare,
così avrà notato anche quel campanile e quella
cappelletta; pur ammettendo che un altro bivio su ad Acquate, ed al
quale ora è crollata la pittura, abbia inspirato la sua
descrizione.
È certo che il Manzoni dalla sua bella casa, allora fuori
alla libera campagna e dove si arrivava e si partiva per strade e
stradette ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, ogni tanto
elevate su terrapieni aperti, egli aveva innanzi spiegato tutto il
magnifico panorama che ha descritto nel suo gran Libro. Tra magnifiche
quinte di cipressi annosi si ammirano le guglie del Resegone, dal
balcone si può godere il lago, l'Adda e poi il lago ancora
fin giù a S. Gerolamo dove si vogliono trovare le rovine del
Castello dell'Innominato.
E quando egli ha dovuto allontanarsi da quei luoghi incantevoli e tanto
cari, ha sentito il bisogno di parlarne e farli celebri in tutto il
mondo. Giunto poi a tarda età, una volta che l'ing. Scola,
il nuovo proprietario della villa, lo era andato ad invitare
perchè si compiacesse di rivedere le antiche possessioni,
egli aveva chiesto con fare melanconico se esistevano ancora le sue
grisaglie, il suo lampadario di Murano, il suo calamaio con la
Maddalena, i suoi mobili e sopratutto i cipressi del suo giardino ; ma
lassù non aveva più voluto ritornare per non
aprire nel suo cuore una troppo dolorosa ferita ». (Arch.
D. G. POLVARA)
|
|
|
|
LA VALLE DELL'ADDA
Avanti
di prendere corso e figura di fiume, l'Adda, uscendo dal lago di Lecco,
forma una serie di laghetti chiamati, dal nome dei paesi più
grossi che vi si specchiano, Lago di Pescate, davanti a Pescarenico,
Lago di Garlate, da Maggianico, a Calolzio, Lago d'Olginate fra questo
paese e Calolzio che gli sta di fronte. Passato Pescarenico, su la
sinistra del laghetto di Pescate, sorge Maggianico, luogo assai
ricercato dai villeggianti per la sua amena giacitura, sebbene poco
elevata, sul lembo del Magnodeno, ch'è uno sprone del
Resegone. Due pale d'altare, una del Luini, l'altra di Gaudenzio
Ferrari, accrescono l'importanza della sua bella parrocchiale. Numerose
le ville. Il cremonese Ponchielli si compiaceva di riposare in
Maggianico e di convitarvi molto frugalmente gli amici. Qui ebbe una
villa anche il celebre operista brasiliano. Carlo Antonio Gomes di
Campines (1839-1896). Presso il paese il torrentello Cino forma una
cascata e v'è anche una copiosa sorgente d'acqua solforosa
fredda utilizzata per malattie cutanee, con apposito stabilimento. E'
frazione di Maggianico il paesello di Chiuso. Continuando su la riva
sinistra s'incontra Vercurago, esso pure alle falde del Resegone, ma
già in territorio di Bergamo, d'onde si può
salire a Somasca, al santuario (294 m.) fondato nel 1528 dal patrizio e
filantropo Girolamo Miani. Sopra Somasca è quella vetta
dirupata che reca le rovine d'un vecchio castello attribuito
all'Innominato. Nelle immediate vicinanze è Calolzio, a
cavaliere delle due valli di S. Martino e d'Erve, ben visibile anche
dall'estremità occidentale della Brianza per il suo fitto
aggruppamento di case e di ville biancheggianti arrampicate anch'esse
su le propaggini del Resegone e discendenti fino alla sponda del Lago
d'Olginate, proprio come branchi di pecore pascenti. Domina il paese
una bella chiesa della prima metà del secolo XIX, progettata
dal Moraglia, cui si accede per una lunga scalinata in pietra. Un alto
pronao su grandiose colonne monolitiche scalpellate da un immane masso
erratico introduce al tempio. Convegno di alpinisti per la partenza e
per il ritorno, Calolzio è altresì ricercato dai
villeggianti ed il vecchio paese è ormai sopraffatto dal
numero delle ville deliziose, cinte di giardini fioriti ed ombrosi,
taluno gemmato di statue, eco lontana delle magnificenze lariane e
della Riviera Ligure.
A circa quattro chilometri da Calolzio, ma più alto,
Rossino, propizio anch'esso alle belle villeggiature e ben visibile da
lontano, specie per il suo rinnovato castello dalle estese mura
merlate, che contrasta alle ruine di Somasca l'onore di avere
appartenuto all'Innominato. Sotto Rossino, il grazioso villaggio di
Corte.
Non volendo però addentrarci più oltre nella
Bergamasca, volgiamoci all'altra sponda dell'Adda, contemplando intanto
il superbo scenario delle boschive montagne dell'alta Brianza orientale
dominate dalla bella vetta del San Ginesio ammantata d'una folta
criniera di cipressi fra i quali occhieggia il candido eremo
camaldolese dei figli di S. Romualdo (859 metri). Passato il lungo e
svelto ponte gettato sul laghetto d'Olginate, troviamo subito questa
degna borgata industriale, che se può invidiare a Calolzio i
vantaggi estetici e panoramici dell'aprica posizione, in compenso gode
d'un'aria più fresca, riparata com'è alle spalle
dal sole. Da Olginate dirigendoci verso il Milanese si entra nella
verdissima Valgreghentino, terra di agricoltori, tutta quiete, che
elevandosi fin sopra i 300 metri gode d'un gran colpo d'occhio su la
valle dell'Adda, la quale, sempre più allargandosi a misura
che si restringe il corso del fiume, si introduce dalla destra nella
ridente Brianza, dalla sinistra sul fervido Bergamasco.
|
|
|
|
VALMADRERA
Ma
se da Olginate ci riaccostiamo al lago di Lecco, incontriamo i colli
che separano la valle dell'Adda da quella d'un altro lago, il piccolo
bacino d'Annone o d'Oggiono, e uno dei primi paesi è
Galbiate, a 370 m., a cavaliere delle due valli, unito da buona strada
con Oggiono e con Lecco. Affrancatosi dalla servitù feudale
nel 1671, rimase preferito soggiorno di nobili e di agiati borghesi,
così che è ricco di palazzotti e di ville, fra
cui notevole quella che il barone Pietro Custodi, economista e
storiografo, continuatore della Storia del Verri, si fece fabbricare
sopra un vecchio convento di cappuccini del sec. XVI, risparmiandone la
chiesa e parte del chiostro. Alla Villa Sanchioli esiste un'eco che
ripete fino ad un endecasillabo. Grandiosa è la chiesa,
ardito e slanciato il campanile architettato dal Brioschi nel secolo
scorso. Da Galbiate si può salire al Barro (922 m.) in circa
due ore, senza gran fatica. Presso la vetta è un albergo. Da
questo monte si gode un'amplissima veduta panoramica, e sopra di esso
riferiva Plinio esser voce che fosse esistito un « oppidum
Orobiorum Barra », un castello degli Orobi chiamato Barra,
dal q Tale sarebbe disceso il popolo che fondò Bergamo.
A mezza costa del monte, verso Lecco, è un'antichissima
chiesa di S. Michele di cui parla lo Stoppani nel suo bozzetto La sagra
di S. Michele, festa celebrata su quelle balze il 29 settembre.
Discendendo a Pescate, davanti al ponte visconteo, e continuando su la
sponda del lago, si giunge a Malgrate, grosso e bel paese che sorge in
faccia a Lecco. In esso avevano casa gli Agudi, ed allora che n'era
proprietario il canonico Candido, il Parini vi godè
ospitalità e vi scrisse parte del Giorno. Il contemporaneo
Balestrieri, poeta meneghino, ivi pure voltava in dialetto la
Gerusalemme Liberata. La chiesa possiede buoni dipinti di Cherubino
Cornienti pavese (1816-1860), l'Annunciazione e la Natività.
Una ventina di metri più sopra sorge il grosso paese
industriale di Valmadrera, che dà il nome alla piccola plaga
circostante. L'industria serica, che vi è rappresentata da
vari opifici, ed altre minori industrie fecero prosperare assai la
economia del comune, conferendogli altresì un aspetto di
civile benessere. La monumentalità della chiesa è
dovuta ai progetti di Simone Cantoni eseguiti poi in parte dal Bovara,
e secondo il Ghislanzoni portò « in quella valle,
melanconica e solitaria, un frammento della grandezza e della pompa
romana ». Le quattro colonne monoliti che della facciata
vennero tolte, al solito, da un masso erratico non molto distante.
L'interno fu decorato d'affreschi dal Sabatelli che vi dipinse
l'Apocalisse.
V'è pure un quadro del Lomazzo, Cristo e S. Antonio, e vi
sono sculture di Benedetto Cacciatori. Di opere d'arte sono decorate
anche le splendide ville dei Gavazzi, fra i primissimi setaioli del
Lecchese.
Dalla Valmandrera si accede alla Valle dell'Oro, di cui è
centro Civate, e che già è Brianza, dominata
dagli alti Corni di Canzo (1372 m.) che il Torti cantò
O selvose montagne o gioghi erbosi,
o di lontan sovreminenti al verde
cornuti massi...
Al di là dei Corni di Canzo è la Valbrona, parte
della Valassina. Dalla Valbrona, più tosto che lungo il lago
di Lecco, privo da questo lato di strada praticabile, si discende per
una recente e pittoresca strada ad Onno, solitario paesino che divide
con Parè, Vassena e Limonta, più prossimo
quest'ultimo a Bellagio, e rivelato al mondo dal Marco Visconti del
Grossi, l'onore dei sedere su questa riva del lago che le alte montagne
a ridosso, nude e dirupate, strapiombanti, cupe e ferrigne,
giù nelle acque, rendono soverchiamente dominata dalle ombre
e priva dei benefici del sole, malinconica e solitaria. Da Vassena una
funicolare aerea per passeggeri, la prima del genere costruita in
Italia, collega quel punto della riva con Civenna in Valassina.
|
|
|
|
VALSASSINA
La
via per la Valsassina si apre in. Lecco stessa movendo dalla stazione
ferroviaria, traversa la grossa borgata di Castello, ormai subborgo.
della città, e San Giovanni alla Castagna - bella
parrocchiale dov'è sepolta la poetessa Francesca Manzoni
(1710-1743) nativa di Barzio, che imparò molte lingue, si
approfondì in varie scienze, fu accademica di più
dotti sodalizi e morì di appena trentatrè anni -
affacciandosi sul verde dei campi e dei giardini e sui folti abitati
industriali. Le acque discendenti dalla montagna recano la forza
dinamica agli stabilimenti e tutta la Valle del Gerenzone è
teatro di una sana operosità. Usciti da San Giovanni, si
trova il Ponte di Malavedo (364 m. ed il villaggio omonimo con
ferriera. Impressionante, vista di qui, la muraglia verticale del Monte
Coltignone, alta 400-m- senza sporgenze. A 420 m. d'altezza
è Laorca, sul Gerenzone, sito in una angusta valle pure
industrialmente operosa come moltissime altre località della
vallata. Poco sopra Laorca è una grotta, pittorica, ma di
scarsa importanza.
Sorpassato il Ponte di Gàina (m. 441) ed il ponticello sul
Gerenzone, salendo per altri duecento metri circa si perviene
all'Albergo del Ristoro, dal cui sito lo sguardo spazia con intensa
soddisfazione dal candido aggruppamento dell'abitato di Lecco, alla
verzura ingioiellata di paesi e di ville del Piano d'Erba. Eccoci
finamente su le alte soglie della Valsassina superba ne'. suoi manti di
smeraldo, con la gola per cui transita il torrente Grigna e la conca di
prati lussureggianti che prende nome da Ballabio. Ma tal nome
è diviso fra due abitati Ballabio Inferiore (653 metri), a
piè del Pizzo Sodatura, cioè sul prolungamento
settentrionale del Resegone, con una chiesa ridotta ad abitazione che
conserva avanzi di pitture quattrocentesche sopra una parete, e
Ballabio Superiore (732 m.), che comanda l'ingresso d'uno dei va!~ Ioni
formati dai contrafforti della Grigna meridionale ed è su la
via più consigliata per salire a quella vetta. Questi luoghi
producono cereali e vini e dànno anche del ferro, ma uno dei
maggiori traffici è il deposito che qui si verifica, grazie
alla particolare benignità climatica, degli stracchini di
Gorgonzola della Bassa lombarda, che nelle « casere
» di Ballabio compiono la loro maturazione prima di essere
asportati. Superato 'il colle di Balisio, con ripida discesa si giunge
ad un altro paesino montagnardo il cui nome indica già il
mestiere degli abitanti : Pasturo (641 m.), dove Renzo, se lo
ricordate, trovò Agnese dopo la peste. Accampato alle falde
orientali della Grigna settentrionale, cui di lì si
può salire in quattr'ore, esso è una
consigliabile tappa per gli alpinisti, che di fatto lo frequentano.
assai, facendolo progredire. I pascoli rigogliosi e le dense boscaglie
lo beneficano di vive tinte e di deliziose frescure.
Nella sua alpestre semplicità è rimasto Bajedo
(632 m.), poco oltre e dalla stessa parte di Ballabio, villaggio di
mandriani che in estate popolano le baite montanine e producono ottimi
latticini. Altri due paesi di vario aspetto, a destra di Pasturo e di
Bajedo, sono Cremeno (797 ml) e Barzio (770 m.), ambedue residenze di
bovari e formaggiai. Nel secondo nacque la poetessa Francesca Manzoni
che trovammo sepolta a S. Giovanni alla Castagna. Valicata la
pittoresca stretta d'Introbio ed il Ponte Chiuso (563 m.), per pochi
metri si sale al paese da cui si denomina la strozzatura. Introbio (586
m.), capoluogo della Valsassina, i cui abitanti sono maestri nel
fabbricare stracchini e robbiole molto pregiate anche all'estero,
specie a Londra, dispone anche, nel territorio, di miniere di barite,
minerale bianco ponderosissimo che si usa per appesantire la carta,
dopo una opportuna macerazione che si eseguisce a Calolzio. Dominante
le strade di Lecco e di Bellano. irrigato dalla Pioverna, torrente
dalle trote eccellenti, reso più maestoso e pittoresco da
una bella torre medievale che serve di campanile alla sua chiesa,
Introbio é anche punto di partenza di magnifiche escursioni.
Interessante quella alla Cascata della Troggia, detta Paradiso dei
cani. cui si giunge in una ventina di minuti e che si rivede nella ben
maggiore ascensione al Pizzo dei Tre Signori, passando per la Valle di
Biandino. Una teleferica va calando a Introbio la galena argentifera
della miniera di Camisolo. Superate le Baite della Scala (m. 1380),
duecento metri più sopra si trova l'altipiano di Biandino
con piccola capanna privata per riposarsi. Dal lato della valle ecco le
grandi pareti del Pizzo, un tempo confine tra il Canton dei Grigioni,
il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, tutte di porfido rosso.
Più in alto (m. 1912) il romito laghetto alpino del Sasso,
poi la Bocchetta di Piazzocco e splendido panorama su la Valle
dell'Inferno, in Valtellina. Quindi la vetta (m. 2554).
Dopo Introbio, alla medesima altezza, il povero paesino di Barcone, pur
dedito all'industria casearia : segue Primaluna (550 m.), luogo
d'origine di quei montagnardi signori che furono i Torriani, i quali
dai loro nidi d'aquile della Valsassina scesero a dominare Milano.
Castello di prim'ordine nel loro vasto feudo fu Primaluna, ma non resta
oggi che un moncone di torre. Altri paesi che nulla offrono oltre le
delizie della splendida natura che li ricinge, ed è
già dono munifico e salutare, sono Pessina (570 m.),
Cortabbio (metri 527), in magnifica posizione dinanzi allo scosceso
versante, settentrionale del Moncodeno su cui si trovano ghiacciai e
nevai che gli abitanti utilizzano per conservare i loro prodotti
caseari, Cortenova (414 m.), Esino Inferiore (750 m.) ed Esino
Superiore (812 m.), teatri di panorami indescrivibili, Bindo, villaggio
di pastori nel fondo della valle, Parlasco (688 m.) dotato di ferro.
Crandola (769 m.), paese di carbonai con una miniera argentifera,
Margno (717 m.), e finalmente Taceno (507 m.) con acque ferruginose ed
albergo, non lontano da una centrale elettrica di 3000 HP. Presso il
Ponte di Taceno (m. 435), che cavalca la Pioverna già
avviata al lago di Lecco, il velario delle montagne sembra chiudere la
Valsassina : al di là è un'altra valle che si
apre, la Val Muggiasca, che prende nome dal Monte Muggio (1791 m), alto
fra i due bacini della Pioverna, con sbocco a Bellano, e del Varrone,
con foce a Dervio.
|
|
|
|
IL SAN MARTINO ED IL RESEGONE
Non
si può descrivere il manzoniano territorio lecchese e
tralasciar di dedicare alcune righe ai due monti che il Manzoni rese
popolarissimi : il S. Martino ed il Resegone. Ma per compiere il nostro
cómpito col rispetto dovuto a tutta una tradizione
letteraria ch'è la più simpatica fra quante ne
conosciamo, dove troviamo di poterlo fare con la penna dei
più illustri e cari seguaci de grande lombardo, no-i7
esitiamo di cedere il campo. Ecco dunque come A più garbato
e il più dotto dei manzoniani, lo Stoppani, descrive il
Monte S. Martino:
«È un monte fantastico, vedete; tutto una rupe,
nuda, aspra, angolosa, degna di campeggiare in un'epopea di giganti. La
città di Lecco si appoggia da tramontana a quello stempiato
macigno e gli è obbligatissima che, slanciandosi ritto come
un muraglione ciclopico, difenda, se non lei propriamente, almeno il
suo ridente territorio dai gelati aquiloni, e riverberandovi i raggi
solari, spesso vi anticipi la primavera nel cuor dell'inverno.
« Il San Martino sorge col suo fianco occidentale
immediatamente dal lago, come una bastia di pietroni a picco, quasi
dappertutto inaccessibili, da cui le frane sterili ed aspre discendono
sino al fondo di quello specchio del più cupo azzurro, che
s'inabissa a' suoi piedi fino alla profondità di 150 metri.
Più su, quella parete a piombo si alza a scaglioni
giganteschi, formando di tratto in tratto pianerottoli e piani
inclinati, sempre intramezzati da altre pareti a picco. Da
mezzodì, ove la montagna è pia nuda, sporge
innanzi nuda nuda la fronte, e nel mezzo di questa si apre un antro
spazioso, come una gran cicatrice, o come l'occhio di Polifemo: segno
probabile, come ce n'ha tant'altri nelle Prealpi, che il mare una volta
ci avventava i suoi flutti. Intendetemi bene. Non è che il
mare si levasse fin là; gli è che il San Martino,
come le Prealpi e le Alpi, come tutte le catene del globo, sorsero dal
mare ; e quindi ci fu tempo che le conchiglie e i pesci del mare
abitavano quegli stessi crepacci, ove ora s'annidano il passero
solitario ed il falco; e come oggidì sulle coste della
Calabria e della Sicilia, così allora, al piede delle
montagne nascenti, rimbombavano gli antri scavati dalla tempesta.
«Al disopra di quella rupe e di quella caverna, la montagna,
continua a salire in forma di piramide, o piuttosto di pina composta di
rupi acute e vertiginose. Dal vertice di essa si discende verso
oriente, sempre d'un modo, fin dove la base della montagna è
rosa all'ingiro dalla Galavesa, detta anche Gerenzone, che è
il più settentrionale di quei tre grossi torrenti, di cui,
nella stessa pagina dei Promessi Sposi, (ne aveva già
parlato) avete letto che formarono coi loro depositi la costiera del
lago.
« Eppure questa montagna, la quale, vista da Lecco, sembra
affatto inaccessibile, non è tale però che non ci
si possano fare delle gite piacevoli ed anche facili. Proprio sulla
fronte, dove sopra la base così scoscesa della montagna
comincia un pochin di pendio, una macchietta bianca attira a
sè gli sguardi di ognuno che venga a Lecco per la via di
Bergamo o di Milano. È la cappelletta di San Martino; e chi
la vede per la prima volta, non la potendo credere un nido d'aquila o
di falco, è forza che domandi a sè stesso chi mai
abbia potuto, non dirò fabbricare delle mura, ma nemmeno
portare il piede lassù. Eppure ci si va così
bene! Dapprima per una valle, o piuttosto per una specie di crepaccio
nascosto in seno alla montagna; poi per una serie di scogli, che
formano come una specie di gradinata. Che vista stupenda si gode da
quel breve pianerottolo sul quale è edificato l'umile
tabernacolo! E di lì un sentiero assai comodo,
benchè quasi volante su precipizi vertiginosi, attraversa
tutta la montagna dalla parte del lago, finchè vi conduce in
un seno, coperto di prati e di boschi, con in mezzo una chiesuola ed un
fabbricato, il quale, benchè denominato comunemente convento
di San Martino, non è e non dev'essere mai stato altro che
una stalla. Oh com'è delizioso quel posto! Com'è
dolce, in mezzi a quella specie di anfiteatro, che si direbbe il tempio
dell'aridità, trovare una così bella verdura!
è là sotto, un piccolo antro nella rupe, che
accoglie un piccolo stagno, nutrito da una fonte fresca e perenne, che
ha tutta l'aria di un perenne miracolo. E poi, e poi...
« Non la finirei più, quando parlo de' miei monti.
Quanto al San Martino, so di un celebre paesista solito dire
ch'è la montagna più bella del mondo. Ed
è tale principalmente per il contrasto tra quel colosso di
rupi ignude che si slancia così ardito nell'aria, e le sue
falde, sparse dapprima di cespugli e di querce, poi di cipressi, di
edere, di lauri, di ulivi, a boschetti, a macchie sempre verdi ; e
più basso, di case e di paeselli, finchè tutto
diviene un gran gruppo di abitati, quasi una sola città, che
discende giù, come un fiume di case, fino a Lecco, fino alla
riva del lago, in mezzo ai campi ed alle vigne, fra il rumore
incessante di cento e cento officine, dove il ferro e la seta si
lavorano con pari abbondanza, e quasi con pari finezza. Lasciatemi dire
anche questa, e poi ho finito. Il Monte San Martino ha la singolare
proprietà che il suo fianco, dove discende verso il lago,
visto di sera, quando il buio ne confonde le disuguaglianze, disegna
con rassomiglianza maravigliosa, il profilo di Napoleone dormente,
assai più colossale del Colosso di Rodi. Non gli manca
nè la fronte protuberante, nè il gran naso
aquilino, nè il mento d'un ovale perfetto. Lo si vede
benissimo disegnato, o dalla via di Bergamo presso Chiuso, a
mezzodì, o dalle pendici sopra Menaggio a settentrione
».
Così nel e Bel Paese », che non tutti gl'Italiani
conoscono, e che troppi italiani grandi dimenticano di aver letto da
piccoli, Antonio Stoppani descrive la sua montagna con l'ardente
affetto di chi v'è nato appresso, con la dottrina dello
scienziato:, con la scioltezza e col colorito dell'uomo di lettere.
Il Resegone però ha una forma ancor più
caratteristica del San Martino, con la sua cresta formata da undici
scoscese punte dolomitiche rassomiglianti veramente ai denti d'una
sega, che in dialetto lombardo si chiama resega, d'onde e el resegon
», per indicare l'arnese ben noto nelle sue gigantesche
proporzioni. Quel monte era popolare in Lombardia, e particolarmente a
Milano, d'onde si scorgeva benissimo - quando non v'era nebbia - dai
Bastioni di Porta Orientale, allor che essi dominavano tutta la
campagna antistante, non occupata, come oggi, dai fabbricati cittadini,
anche prima che il Manzoni vi richiamasse l'attenzione del pubblico con
l'accenno fattone iniziando il suo romanzo. Da ogni parte poi del
territorio che si stende fra Milano e Como l'occhio incontra sempre
quel bruno a ceruleo schieramento dentario, a traverso il quale
è bello dall'alta Brianza veder sorgere il sole che in
estate va scorrendo tutte le dieci finestre, successivamente
affacciandosi a ciascuna di esse. È noto, l'errore del
Carducci che, per aggiungere forza alla pittorica descrizione del
Parlamento milanese soddisfatto d'aver decisa la guerra contro il
Barbarossa, termina le strofe con una pennellata magistrale, sebbene
sbagliata
Il sole ridea calando dietro il Resegone.
Secondo il punto di vista dei Milanesi il Resegone si trova a
settentrione, quindi impossibile che il sole calasse da quella parte;
ma fu giustificato l'errore del poeta osservando che, veduto da un
altro punto, può anche dare l'impressione di trovarsi. a
occidente.
Pur questo monte, ormai classico, offre piacevoli ascensioni. La sua
altezza massima è di m. 1875 e le sue pareti sono solcate da
canali profondamente scavati entro i quali di solito si vede
biancheggiare la neve, divisa in candidi ruscelli, anche dopo che le
vette l'hanno scossa, Da Acquate si può salire in due ore
alla Capanna Stoppani del Club Alpino Italiano (m. 820); poi per la Ca
Dàina e a traverso la parte superiore della Val d'Erve, in
cinque ore, si giunge alla vetta, dove da poco sorgono due rifugi
privati. Dalla Capanna Stoppani si sale anche al dirupato Pizzo d'Erna
(m. 1375).
Ma non sono le ascensioni al San Martino ed al Resegone quelle
più ambite dagli alpinisti.
|
|
LE GRIGNE
L'escursione
alpinistica più popolare in Lombardia è quella su
le due Grigne, imponente massiccio dolomitico che sorge su la sponda
orientale del lago di Lecco e domina l'intiera Valsassina, Anzi tutto
enumeriamo le vie d'accesso alle due vette.
Alla Grigna Meridionale (m. 2184); sei vie Lecco-Ballabio
Superiore-Capanna Escursionisti Milanesi-Albergo Carlo Porta -
Lecco-Laorca SuperioreCapanna detta-detto albergo - Abbadia-Piano dei Re
sinelli-Capanna e albergo detti - Mandello, poi come il precedente -
Mandello-Capanna Rosalba per la cresta Segantini (difficile) -
Mandello-Capanna dettasentiero Cecilia (non facile).
Alla Grigna Settentrionale (m. 2410); quattro vie Ballabio-
Balisio-Capanna Pialeral-Cresta Sud-Grigna Vetta - Mandello-Capanna
Releccio-Canalino - Mandello-Capanna detta-Canalone (difficile) -
Varenna-Esino-Capanna Monza-Grigna Vetta.
Ed ecco ora le impressioni sulle Grigne che un escursionista
manifestava anni sono nel Bollettino Municipale di Milano (luglio 1919)
«La via più comune per salire alla Grigna
meridionale o Grignetta è quella che, da Ballabio superiore,
sale all'albergo rifugio Carlo Porta, via mulattiera abbastanza comoda
tra boschine e strette lingue di prati. Appena si è in vista
dell'albergo eretto alla base del massiccio della Grigna e si lascia
alle spalle la vallata, si ha l'impressione del paesaggio d'alta
montagna prati e pascoli, baite basse e larghe sullo sfondo, rupi
scoscese enormi che si innalzano a picco, e il frequente mutar delle
luci e dei colori dal roseo, all'indaco, al violetto, al turchino, al
verde e al nero. Se l'atmosfera è variabile, il panorama
cambia ogni pochi minuti. Nella cortina di nubi si aprono
all'improvviso larghe finestre dalle quali si scorgono il lago, l'Adda,
la pianura lombarda, il Resegone velato.
« Anche la Grigna, abitualmente corrucciata, .non si mostra
troppo di frequente nella sua nudità. Par quasi che sulla
vetta i nembi velino qualche strano rito, qualche grande amplesso di
esseri sovrumani.
« L'enorme blocco montagnoso delimitato a semicerchio dalla
Valsassina e sull'altro lato del lago di Lecco e chiuso in un anello di
malachite e di lapislazzuli, sembra difendersi dall'assalto degli
abitanti della metropoli così vicina con
l'asperità dei suoi contrafforti e dei suoi costoni e, per
irrisione ai loro sforzi, e alla loro curiosità, con la
cortina dei suoi vapori.
« Chi voglia cimentarsi agli acrobatismi sulle pareti
verticali in roccia ha a sua scelta i torrioni Magnaghi, l'ago
Teresita, la punta Angelini, la cresta Segantini, i torrioni Cecilia,
la guglia Cinquantenario, il Sigaro e può trovare ancora
qualche punta che aspetta l'audace che la calchi per la prima volta e
la battezzi.
« La salita dall'albergo Porta alla vetta per il sentiero
Cermenati è una passeggiata ben nota ai gitanti che
l'affrontano anche con scarpe da Galleria. La maggior fatica sta nel
superare, in principio, il ripido dorso della montagna, ma lo
spettacolo rende lo sforzo meno sensibile. Ai due lati sorgono gli
scheggioni, le punte, gli aghi che sembrano il rifugio dei Giganti
precipitati da Giove.
« Sotto, si stende sempre più vasto, il piano ; i
laghi si scoprono, si allargano, si accendono al sole, diventano di
smeraldo, di lapislazzuli, di opale. Di notte, il velo cupo che copre
il lago è forato dai riflettori dei doganieri e, in fondo,
la pianura è chiusa dalla via lattea formata dai lumi della
metropoli. Poco lungi dalla- vetta, a sinistra, si stacca il sentiero
che conduce alla capanna Rosalba per il sentiero Cecilia. Questo
procede or dentro or fuori, tra gli scheggioni che formano la cresta
Segantini la quale dà la sensazione della
terribilità delle convulsioni della natura nelle epoche
millenarie in cui si formarono i corrugamenti della crosta terrestre,
aiutando il fuoco, i terremoti e, più lentamente, i nembi e
le erosioni.
« Dalla capanna Rosalba si può tornare all'Albergo
Porta per un sentiero lungo coste erbose, per boschi di un verde
così smeraldino e trasparente sul fondo azzurro del cielo che
è dolce allora o sotto un'elce antiqua
o su folt'erba stendersi
mentre fra l'alte ripe l'acque scorrono,
gli augei ne' boschi lagnansi,
per le sgorganti linfe i fonti scrosciano,
leggeri sonni a porgere.
(ORAZIO, Ep. 11, 23-28).
« Anche il sentiero che conduce dal pianoro dell'Albergo
Porta alla capanna Pialeral passa attraverso prati e boschi. Esso
è segnato e non è consigliabile abbandonare il
segno. 1 sentieri rappresentano l'esperienza millenaria dei popoli
fanno coincidere il tempo con quel tanto di comodità che
è possibile in montagna. Voler abbandonare il sentiero
significa, spesso, perdere tempo.
« Nel tragitto, lungo i fianchi delle due Grigne, nella
fresca oscurità meridiana dell'interno di una baita la
polenta fumante raggia come una luna piena; più innanzi una
polla d'acqua cristallina reca una gradita sorpresa per chi sa quanto
povero d'acqua sia il massiccio delle Grigne.
« La capanna Pialeral sta a guardia della conca degli
sciatori, tanto questa, nell'inverno, è frequentata dagli
amatori di questo rapido mezzo di locomozione proprio delle grandi
pianure di neve e di ghiaccio del nord.
«Sulla Grigna settetrionale, il Grignone, la solitudine e il
silenzio sono assoluti. L'uomo non può intavolare un dialogo
che con sè stesso, in cospetto alla natura.
« Di lassù, il sorgere del sole, in estate, nella
Valsassina verde, non si dimentica mai più. Quando, superata
la cortina di nubi, il disco appare nitido, ampio, fiammeggiante, a
occidente, la catena del Rosa, come sospesa nello spazio per
incantesimo, si colora della più dolce tinta. Il cielo
presenta tutta la gamma dal grigio al verde, al celestino trasparente.
Il lago, in fondo, è ancora plumbeo. I punti più
prossimi diventano di oro verde. Di tra le cime più alte
delle catene ad oriente i raggi arrivano tangenti, e, superando in alto
le valli, vanno a rosare altre cime minori.
« Uno stormo di corvi si alza gracchiando dai cratere spento
che sta sotto il rifugio. Dal fondo valle salgono i primi squilli delle
campane e degli armenti : la vita degli uomini riprende il suo ritmo.
« Ora l'atmosfera nel semicerchio della Valsassina
è tutto un pulviscolo verde. La Grignetta, ancora violastra,
si sveglia a fatica, si stira, aspetta un raggio diretto per
imbellettarsi di rosa e liberarsi dal brivido freddo del primo albore.
Ma il sole ha vinto tutte le barriere che le nubi avevano frapposto al
suo folgoreggiare. A mano a mano che esso sale nel cielo, i suoi raggi,
percotendo direttamente la roccia, riattivano la fabbrica dei vapori:
un fiocco di bambagia si stacca da una anfrattuosità, si
innalza, si allarga, si unisce ad un altro ; insieme fanno catena ; la
loro diafanità si ispessisce, si oscura ; la nube
è formata e naviga nel cielo, verso il sole dove sembra
nuovamente scemare, disfarsi, disperdersi nel nulla.
«Talvolta i fumi della montagna formano un velario opaco che
ne avvolge e chiude tutt'attorno alla vista l'orizzonte, permettendo di
immaginare, come oltre la siepe sull'ermo colle, l'infinito coi suoi
spazi, i suoi orrori, i suoi terrori e i suoi sogni, che son poi quelli
della nostra fantasia, del nostro spirito ».
Monografia redatta da Pio Pecchiai, con la
collaborazione, per la parte manzoniana, di D. Giuseppe Polvara, del
quale sono anche gran parte delle fotografie.
|
 |

